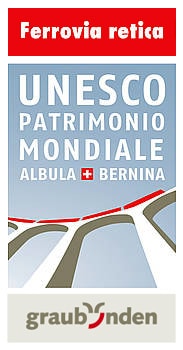La rupe spaccata
Doveva pur essere bella, questa nostra valle ancor tanto selvaggia, quando, nella florescenza del medio Evo, vi si vedevan sorgere, su qualche poggio superbo di scabrose rocce e di giganteschi alberi, i cupi castelli merlati dei signori stranieri. Uno dei quali, viste le ricchezze dei boschi e dei campi, pensò bene che, a saper fare, avrebbe potuto trarne un bel profitto. E mandò in valle un castellano aguzzino e crudele, col comando di far mano bassa su tutto quanto vi avesse trovato di bello e di buono. Costui era un omaccio che a esser cattivo con la povera gente ci trovava gusto. S’annidò con buona schiera d’altri malfattori nel castellaccio di Pedenale e di là, notte e giorno, usciva a compiere ruberie e soprusi ch’era uno spavento.
Quando sui campi sorgevan le biche dei grani, affastellate con tanto sudore, e nei prati s’accumulavano gli odorosi mucchi del fieno ben assecchito, arrivava il signorotto coi suoi cavalli e coi suoi carri, a portarsi via tutto, sghignazzando in faccia ai contadini stupiti: «Vigliacchi, nati per sudar su l’aratro e per soffrir la fame, voglio farvi vedere s’io mi merito il nome di padrone». E se c’era qualche bella bestia, era per le sue stalle. Se c’era qualche giovane bello e forte, era per i suoi servigi. Così nel castello si godeva sicuro la vita, assieme a tant’altri che, a ubbidirlo, vi trovavano più di un vantaggio; mentre i poveri valligiani morivano di fame e di fatica. E se volevano aver salva la vita, dovevano sopportare e tacere; e non dimenticarsi poi di fare un bell’inchino al castellano, se mai l’incontravano quando scorazzava, spavaldo in groppa al suo cavallo, per i prati, per i campi e per i boschi dei dintorni.
Tutti gli auguravano che il diavolo se lo portasse all’inferno. E fra i pegio inaspriti c’era un sant’uomo che abitava in Prada: il borghetto più vicino al castello e fatto di poche case infilate di qua e di là della straducole che, uscita dai prati, l’attraversava guizzando quasi di porta in porta come se fosse vogliosa di rientrare subito nell’ampia prateria che dà il nome al villaggio. Il buon uomo, che aveva moglie e figliuoli e sapeva quanto è dura la vita del contadino, godendo qualche agiatezza, era molto caritatevole e pietoso. Per questo non poteva soffrire le
crudeltà del tiranno ed era quello che più di tutti se ne lagnava. Il signore del castello, temendo che il contadino, coi suoi lamenti, finisse per sollevargli contri tutti gli altri, gli volle dare una buona lezione. E ricorse al solito metodo. Aspettò l’agosto, e quando vide i prati e i campi del pover’uomo colmi di gente a far fieno e grano, vi mandò i suoi omacci armati; i quali, in quattro e quattr’otto, si portarono via tutto, pagando a fior di pugni e sghignazzi. Ma il poveraccio era, oltre che mite e misericordioso coi poveri, assai coraggioso e forte e le ingiustizie lo facevan violento e vendicativo. Stavolta era poi la roba sua che andava di mezzo e senza pensare alle certe conseguenze di ciò che voleva fare, afferrò un tridente; i primi tre o quattro manigoldi che se l’ebbero addosso, pagarono assari cara quell’ultima crudeltà. Perché doveva proprio esser l’ultima! Ma il disgraziato doveva prima pagare fio di quella sua temerarietà. Disarmato e condotto al castello, il signorotto s’inviperì a sentirsi raccontare quanto quegli aveva avuto il coraggio di compiere. E l’avrebbe certo fatto impiccare, se il diavolo non fosse stato pronto a suggerirgli un’atrocità ancora più orribile. Si divertì a fargli cavar gli occhi con un ferro rovente e a mozzargli le dita delle mani. Poi lo fece ricondurre a casa sua, dove gli sgherri lo lasciarono, cieco e mondo, a piangere insieme alla sua donna e ai suoi bambini. Ma prima di ritornare al loro covo, quelle bestie feroci gli svuotarono la casa e la stalla di quel poco che vi era rimasto e, non contenti del furto, vi appiccarono il fuoco.
Ora toccava alla giustizia di Dio. Il povero cieco era stato abbastanza punito per quell’atto d’insurrezione assai scusabile, anzi lodevole, per un uomo di così nobil cuore com’egli era Girellava di porta in porta, condotto da uno o l’altro dei suoi figliuoletti e chiedeva la carità a quelli cui prima egli stesso l’aveva data. E il raccapricciante spettacolo ch’egli offriva ora, mostrando le occhiaie vuote e i moncherini sanguinanti, era un grido di vendetta contro il tiranno, ben più incitante e più convincente dei lamenti che s’udivan prima dalle sue labbra. Ma il castellano continuava a godersi la vita, assieme ai suoi nibbi, come se nulla di nuovo fosse accaduto. Un giorno cacciava allegramente nei boschi vicino ai monti di Selva: un bel luogo pianeggiante a metà costa, coltivato a prati, dove il po
veretto ch’egli aveva ridotto in miseria, possedeva ancora una baita e alcune pezze di terra. La strada che, salendo dal piano, vi giungeva da settentrione, passava vicino a una gran roccia, la quale sorgeva dal terreno e restava lì isolata, nuda e cupa, in mezzo al chiaro verde dei prati.
La chiamavano – e il nome vi e rimasto – il sasso di Macòn.
Minacciava il temporale. Il cacciatore spronava il cavallo per giungere in fretta a qualche casa dei monti dove avrebbe chiesto ricovero con la solita sua prepotenza. Giunto vicino alla rupe che, in quell’ora foriera di tempesta, nereggiava più cupa sotto il cielo annuvolato, il cavallo gli s’impennò di scatto: seduta contro il sasso, stava una donna con un bambino in grembo. La poveretta, visto il signorotto, s’alzò spaurita e mostrandogli il neonato che piangeva, stese la mano e chiese l’elemosina. Il cavaliere le domandò chi fosse.
«Sono la mogie di quell’uomo che voi avete accecato. Ci avete tolto il pane di bocca, signore. Moriamo di fame. Fatteci almeno la carità per un giorno. Iddio vi perdonerà».
Il signorotto si guardò la ricca cintura, da cui gli pendeva la borsa gonfia di monete. Poi scrutò il cielo e, scoppiando a ridere, spronò la bestia a procedere. Ma la donna si era rizzata in mezzo alla stretta via e il cavallo scalpitava senza muovre un passo. Il tiranno bestemmiò. «Tirati da parte, donnaccia».
La disgraziata, arsa dall’ira e dalla fame, innalzò verso il tiranno il suo bambino strillante e gli gridò: «se non volete soccorrerci, se ci avete tolto chi ci dava il pane, tenetevi almeno questo innocente. Nutritelo voi».
Lo sciagurato s’incrinò verso la donna, afferrò il bambino per un piede e roteandolo come uno straccio nell’aria, lo scaraventò furioso contro la rupe. Il misero corpicciuolo si spiaccicò sul sasso, mentre il cavallo, spronato a sangue, s’impennava nitrendo, senza proseguir d’un passo. Poi, d’un tratto, fra gli urli della madre disperata e il rumoregiare dei primi tuoni nel cielo incupito, si sbandò verso la rupe e vi salì sopra d’un balzo.
Nel medesimo istante, fragoreggiando come una montagna che sdirupa, sfolgoreggiò il fulmine. La rupe si spaccò: cavallo e cavaliere sparirono inghiottiti nell’orrenda voragine, aperta dalla vendetta di Dio.
E giù nella valle, in mezzo al furore della tempesta, gli uomini insorti contro il tiranno assalivano il castello, saccheggiandolo e bruciando ogni cosa.
Finiva così la tirrania del castellano di Pedenale. Della sua rocca non rimangono che poche rovine, e il nome alla fertile collina su cui torreggiava un tempo, bella fra i selvaggi alberi che la circondavan di verde; maledetta però dalla povera gente della valle, che ne odiava il signore. Di lui rimane il truce ricordo; e, a fianco della viuzza che dal piano conduce ai bei prati di Selva, la rupe spaccata che l’inghiottì. Dai fessi vi spunta qualche ciuffo d’erba riarsa e qualche ramuzzo di cespuglio, bruciacchiato dai fulmini.
E di notte quando dalle cime scende il vento e la bufera, vi si scorge sopra, al chiaror delle folgori, l’ombra di un uomo a cavallo, che esce e riprecipita imprecando nella voragine.